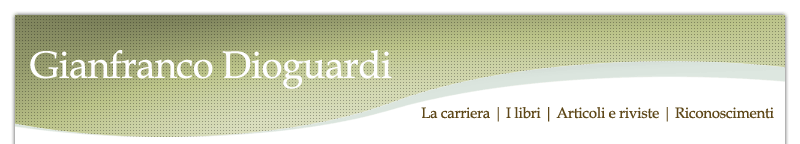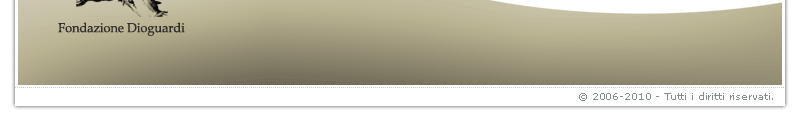|
 Alla ricerca dello spirito imprenditoriale Alla ricerca dello spirito imprenditoriale
 La Delega tecnologica La Delega tecnologica
 L'imprenditore nella complessità e nei mutamenti degli scenari di new economy L'imprenditore nella complessità e nei mutamenti degli scenari di new economy
 Strategia: antichi insegnamenti per l'imprenditore Strategia: antichi insegnamenti per l'imprenditore
 Elogio della fortuna imprenditoriale Elogio della fortuna imprenditoriale
 Dominare la nuova corte barocca imprenditoriale Dominare la nuova corte barocca imprenditoriale
 Parchi tecnologici Parchi tecnologici
 Strategia ovvero la struttura in azione Strategia ovvero la struttura in azione
 Imprenditore ovvero Entrepreneur Imprenditore ovvero Entrepreneur
 Infomatica:una nuova frontiera Infomatica:una nuova frontiera
Strategia: ovvero la struttura in azione
Strategia come gioco
Il fanciullo dei «perché» è avido di conoscere, ma gli piace anche giocare. Non bisogna credere che ciò sia per lui un'occupazione inutile: il gioco insegna a riflettere, a vedere e poi superare le difficoltà, qualche volta persino a divertirsi con esse. Non vi è gioco , per quanto spontaneo, che non possieda una sua tattica e una sua strategia. Perciò, il gusto per il gioco non è esclusivo dell'infanzia o della prima giovinezza: non esiste uomo maturo, per quanto serio possa essere, che non ne conservi un poco in fondo all'animo. E non esistono forse taluni giochi (quello degli scacchi ne è un esempio), che esigono molta riflessione e persino ragionamento? Svelare un enigma, trovare la soluzione di una sciarada, non significa forse cercare di scoprire qualcosa di nascosto, e non è questo una specie di sforzo analogo alla ricerca scientifica? Inoltre, credo si possa affermare che il gusto per il gioco, che è come la curiosità una tendenza naturale nel fanciullo, ma che non è però infantile nel senso peggiorativo della parola, abbia anch'esso contribuito al progresso della scienza. Quando lo scienziato cerca di comprendere certi fenomeni naturali, comincia con l'ammettere che questi fenomeni obbediscano a determinate leggi che possiamo valutare in quanto comprensibili al nostro intelletto. Questo -- notiamolo bene -- non è un postulato evidente e senza importanza: porta infatti ad ammettere la razionalità del mondo fisico, a riconoscere che c'è qualcosa in comune tra la struttura materiale dell'universo e le leggi che regolano il nostro spirito. Ammessa questa ipotesi, che riteniamo naturale e la cui arditezza non ci curiamo mai di esaminare, noi cerchiamo di ritrovare i rapporti razionali che, secondo essa, devono esistere tra le apparenze sensibili.
Strategie d’impresa
Con la rivoluzione industriale e l'affermarsi della impresa produttiva si incominciarono ad attuare sullo scenario socio-economico varie forme di strategia organizzativa dalle quali si sono potuti trovare elementi utili per tentarne una sua teorizzazione.
Nel 1962 presso il MIT (Massachussets Institute of Thechnology) lo storico americano Alfred D. Chandler Jr. pubblicava Strategy and structure: Chapters in the history of the American Industrial Enterprise (tr.it.Strategia e struttura: storia della grande impresa americana, Milano, 1976) , un libro destinato a sancire ufficialmente e definitivamente il ricordo che la strategia deve avere nell'ambito della impresa cercando di liberarla dai significati moralmente meno qualificanti che l'origine della parola tuttavia continua a portare con sé.
Secondo Chandler: «La tesi secondo la quale differenti forme organizzative risultano da differrenti tipi di sviluppo può essere enunciata con maggiore rigore se la pianificazione e la gestione dello svilppo vengono definiti una strategia, mentre l’organizzazione progettata e costruita per amministrare i settori di attività e le risorse vengono definite una struttura. Si può definire strategia la determinazione delle mete fondamentali e degli obiettivi di lungo periodo di un’impresa, la scelta dei criteri di azione e il tipo di allocazione delle risorse necessarie alla realizzazione degli obiettivi suddetti».
La conclusione alle quali perviene lo studioso bostoniano, che fu anche docente di «business history» ad Harvard, è che: «La struttura consegue alla strategia e che il tipo più complesso di struttura è il risultato della concatenazione di diverse strategie di base».
Strategia e struttura
Dunque, secondo Chandler, è la strategia a determinare la struttura organizzativa in grado di conseguire gli obiettivi che si vogliono raggiungere. La strategia deve cioè individuare prima, e costruire poi, una serie di fattori e di eventi concatenandoli fra loro spazialmente e nel tempo, in modo da cercare di mantenere su di essi un costante condizionamento di guida, capace di contrastare o assecondare la concatenazione dei fatti esterni, che si verificano al di fuori della nostra volontà, a seconda che si presentino contrari o favorevoli alle nostre aspettative. Così, la struttura deve vivere un continuo aggiustamento strategico sia in funzione degli effetti che essa provoca sui fatti ambientali, sia in base ai condizionamenti che necessariamente intervengono per effetto degli eventi esterni indipendenti da essa.
Agire pratico
Dall'arte militare alla scienza, dal mondo dei giochi a quello delle imprese, la strategia comunque ispira sempre il comportamento del protagonista. Come tale può essere definita «morale», ma soltanto in senso etimologico come categoria dello spririto che riguarda l'agire pratico. E così si possono incontrare le sue diverse interpretazioni riandando a esaminare la stessa storia del pensiero umano. Si ritroveranno sue tracce, alle volte soltanto accennate, altre volte molto più profonde e bene individuate in una ricerca che si presenta molto simile a quella battuta di caccia cui faceva cenno Bacone.
Proprio Sir Francis Bacon, trentaseienne, pubblicò nel 1597 la prima edizione dei suoi Essays. Sui modi di affrontare le faccende del mondo esaminati in dieci specifici argomenti, destinati ad aumentare a man a mano che con gli anni il pensatore inglese accumulava esperienza di vita. Diventavano così quaranta nell'edizione del 1612 e cinquantasette in quella del 1625. In essi si studia il comportamento che deve assumere il cortigiano per imporsi sugli intrighi di corte, non molto diversi da quelli che oggi caratterizzano l'ambiente aziendale e la «business competition».
Bacone
Filosofo di eccezionale valore, ma anche, sotto il regno di Giacomo I, Lord Cancelliere, barone di Verulanio e visconte di Sant'Albano, Bacone seppe conciliare con alterna fortuna la difficile contrapposizione di sapere e potere. Una diretta testimonianza della sua capacità di coniugare contrapposti pensieri è per esempio suggerita dalla lettura del primo dei suoi Saggi (Palermo 1996), che intitolato Della Verità, costituisce in realtà l'elogio del suo opposto: «Comunque, a far prediligere la menzogna, non è soltanto la difficoltà e la fatica che gli uomini sopportano nello scoprire la verità, e neanche il fatto che, una volta trovatala, controlli le loro opinioni, bensì l’amore naturale, sebbene corrotto, della menzogna stessa. […] L’aggiunta di una menzogna accresce sempre il piacere. Qualcuno dubita forse che, se alla mente umana si togliessero idee vane, speranze lusinghiere, valutazioni false, fantasticherie, vagheggiamenti e simili, non resterebbero nelle menti di molti uomini altro che povere, inaridite cose piene di malinconia e malanimo, sgradevoli a loro stesse? Uno dei Padri, con grande severità, chiamò la poesia il vino dei demoni, poiché colma l’immaginazione e ci riesce solo con l’ombra della menzogna.». E poi, come ricorda Augusto Guzzo, il decano dei filosofi italiani: «Star attenti, dice Bacone, a non infastidire, a non ferire con scherzi inopportuni, a non fingere di non sapere quel che si sa, se non si vuol essere sospettati di sapere anche quello che in realtà si ignora. Bisogna essere egualmente capaci di discorrere lungamente e di interloquire a tempo debito; e guardarsi sia dall'annoiare coi preamboli, sia dal colpire entrando troppo bruscamente in argomento. Nella conversazione, saper essere cortesi senza però troppo studio e affettazione ...» , e via dicendo con una serie di affermazioni che, spesso sgradevoli nella loro esaltazione, costituiscono purtroppo una caratterizzazione assai diffusa dei consessi così detti sociali.
Riferimenti
Nelle sue riflessioni il filosofo inglese riprende la tradizione italiana di Machiavelli e dei trattatisti cinquecenteschi, anticipando i pensatori del '600 e in particolare lo spagnolo Baltasar Gracián , il più interessante forse fra gli studiosi del comportamento. In particolare moltissime delle tematiche svolte nei saggi baconiani sono riproposte nell'opera più significativa di Gracián : L'oracolo manuale del 1647, nel cui titolo si ritrova proprio la traccia del Manuale di Epitteto opera che rappresenta il riferimento più antico, ma anche più significativo per questo genere di indagine.
|