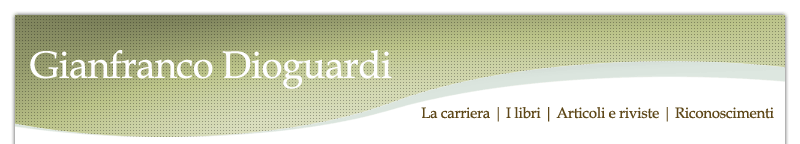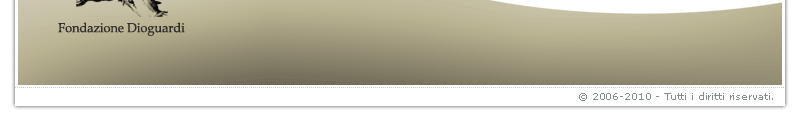|
 Alla ricerca dello spirito imprenditoriale Alla ricerca dello spirito imprenditoriale
 La Delega tecnologica La Delega tecnologica
 L'imprenditore nella complessità e nei mutamenti degli scenari di new economy L'imprenditore nella complessità e nei mutamenti degli scenari di new economy
 Strategia: antichi insegnamenti per l'imprenditore Strategia: antichi insegnamenti per l'imprenditore
 Elogio della fortuna imprenditoriale Elogio della fortuna imprenditoriale
 Dominare la nuova corte barocca imprenditoriale Dominare la nuova corte barocca imprenditoriale
 Parchi tecnologici Parchi tecnologici
 Strategia ovvero la struttura in azione Strategia ovvero la struttura in azione
 Imprenditore ovvero Entrepreneur Imprenditore ovvero Entrepreneur
 Infomatica:una nuova frontiera Infomatica:una nuova frontiera
Strategia: antichi insegnamenti per l’imprenditore
Di Gianfranco Dioguardi
Il Manuale di Epitteto si apre con questa affermazione: "Le cose sono di due maniere: alcune in poter nostro, altre no.”
Di per sé potrebbe già costituire oggetto di meditazione per costruire utili strategie operative.
Epitetto
Epitteto (50 circa - 124/130 circa d.C.) fu uno schiavo frigio che visse a Roma. “Il suo padrone Epafrodito - che taluni identificarono con il famoso liberto di Nerone - con fredda crudeltà lo storpiò. Mentre lo strumento di tortura gli torceva la gamba, Epitteto si contentò di osservare al torturatore: “Bada che la romperai!” E poiché di fatto si ruppe lo schiavo aggiunse, semplicemente: “Te l'avevo pur detto!””. Questo racconto pietoso ci deriva da Celso, le cui pagine ne sono riportate da Origene (“Contra Celsum”, III, 368)”.
Così lo presenta Vincenzo Cilento nel Dizionario degli Autori Bompiani, per testimoniare il disprezzo per il dolore che portò Epitteto a diventare un maestro di morale stoica. La fama di amante del ragionare filosofico lo fece espellere da Roma quando, nel 90 d.C., furono emessi gli editti contro i filosofi, gli astronomi e i matematici. Si ritirò in Nicopoli, nell'Epiro, dove continuò una vita dedicata agli insegnamenti morali che un suo allievo, Flavio Arriano di Nicomedia, raccolse sotto forma di massime nelle Dissertazioni e nel Manuale.
Comportamenti strategici
Tutta la filosofia morale che il Manuale di Epitteto esprime come regole del comportamento e dell'azione pratica può stimolare utili ripensamenti per formulare strategie per districarsi in quelle contorte vicende umane nelle quali spesso l’impresa (ciascuno di noi) è coinvolta nella sua vita quotidiana.
Qualsiasi struttura organizzativa, impresa o altra entità sociale, per conseguire gli obiettivi per i quali è nata deve porre in atto una sua propria strategia.
Strategia - tattica
L'origine semantica, grecolatina, della parola “strategia” è la medesima di “stratagemma”. Da “stratos”, accampamento, armata e “egema” atto di condurre, di guidare. Quindi entrambe contengono in sé il significato letterale di “condottiero d'esercito”. Che nel caso di stratagemma si trasforma, secondo il Vocabolario degli Accademici della Crusca, in “frode militare con la quale si procura di apportare danno all'inimico”, mentre strategia acquista il senso di arte bellica che regola e coordina le varie operazioni generali in vista dello scopo finale della guerra. Concetto, quindi, più ampio di quello di tattica, che consiste nell'ordinare l'esercito sul teatro delle operazioni preparandolo per la singola battaglia. Il senso attribuito a «strategia», poi, si amplia ancora per diventare quello di “capacità di impiegare astuzie e artifizi per il raggiungimento di uno scopo”. Che è poi ciò che noi sottintendiamo, in ambito organizzativo, quando usiamo con ostentazione il termine per giustificare le azioni e i mezzi spesso leciti, qualche volta fraudolenti, per conseguire i fini e gli obiettivi che si definiscono in particolare nella dura lotta per la supremazia imprenditoriale.
Ricerca operativa
Nel linguaggio delle imprese la parola “strategia”, di cui oggi si fa largo uso e forse abuso, è stata introdotta attraverso la Ricerca Operativa. E' questa una scienza che si occupa di ottimizzare le decisioni attraverso metodi e modelli prevalentemente matematici basati perciò su di una accentuata astrazione del reale. Uno dei suoi capitoli più importanti riguarda la “teoria dei giochi”- eufemistico modo di rappresentare, fra l'altro, le vicende belliche indicandole come gioco fra diversi contendenti. Gioco assai pericoloso quando si passa dall'astratta esercitazione logica, eseguita a tavolino, alla sua concreta rappresentazione sul campo di battaglia.
In questi esercizi la strategia serve a indicare l'insieme di regole che consentano di stabilire e decidere le mosse per conseguire la vittoria. Per raggiungere questo fine è necessario usare grande astuzia e porre in atto artifici tali da confondere le idee dell'avversario, facendolo cadere in una trappola da cui non sappia più uscire. Proprio come la descrive Clemente Ancona nella voce «tattica strategia» della Enciclopedia Einaudi, parlando della “la metafora del labirinto”: “I due comandanti avversari potrebbero immaginarsi come altrettanti architetti di labirinti, e la strategia di ciascuno come l'opera di progettazione di un labirinto”. Quest'ultimo a sua volta potrebbe considerarsi come l'equivalente di una situazione militare d'insieme. Il comandante che fosse riuscito a creare quest'ultima, e a imporla all'avversario dimostratosi incapace di evitarla, manterrebbe, nella finzione, il suo ruolo di architetto, mentre l'avversario è come se venisse declassato al ruolo di viaggiatore smarrito dentro il labirinto, «senza né mappa né bussola”.
In vista di un confronto, ciascuno degli architetti-strateghi si accingerà a preparare il suo progetto-strategia, cercando al tempo stesso di impedire che l'avversario faccia altrettanto e di evitare inoltre che il medesimo lo ostacoli nella sua opera.
Labirinti
viaggiatori smarriti in un labirinto “naturale”.
1)In un labirinto naturale viene a trovarsi anche lo scienziato indagatore che va alla ricerca di carpire alla natura, con astuzia, le sue segrete leggi per mettere ordine nell'intendimento dei fenomeni che la rappresentano. Secondo Claude Bernard nel suo “Introduction à l'étude de la médecine expérimentale”,(Introduzione allo studio della medicina sperimentale, Milano, 1973): “Le circostanze più diverse possono servire di punto di partenza per una ricerca scientifica ... Molto spesso le idee sperimentali sorgono per caso in seguito a una osservazione fortuita ... Si va a zonzo, per così dire, nel regno della scienza e ci si mette dietro a quello che casualmente può presentarcisi dinanzi. Come dice Bacone, la ricerca scientifica è una specie di battuta di caccia e le osservazioni sono la selvaggina”. Questo significa porre in atto, anche in campo scientifico, un’adeguata strategia. Che per avere successo, come in guerra o negli affari, deve essere ricca di sempre nuova capacità inventiva da alimentare, usualmente, attraverso sentimenti di meraviglia sorpresa e ammirazione.
Storia
Come suggeriva Adam Smith alla scoperta de «The Principles which lead and direct philosophical enquiries illustred by the history of astronomy» (“I principi che guidano e dirigono le ricerche filosofiche, illustrate dalla storia dell’astronomia”, in Saggi Filosofici, Milano, 1984): “Wonder, surprise and admiration” Meraviglia, sorpresa e ammirazione sono parole che, nonostante vengano spesso confuse, nella nostra lingua denotano sentimenti che sono effettivamente affini, ma anche diversi e distinti l'uno dall'altro per alcuni aspetti. Ciò che è nuovo e singolare suscita il sentimento che con proprietà si chiama meraviglia; ciò che è inatteso origina la sorpresa, e ciò che è grande e bello l'ammirazione”.
Curiosità
Sentimenti che devono accompagnarsi alla curiosità per le cose del mondo, altra caratteristica fondamentale per realizzare la ricerca e comunque conseguire strategie di carattere innovativo. Proprio come avviene nei giochi -- quelli veri e non di guerra, sui quali i bambini inventano continue modificazioni di condotta anche se i temi di base sono quelli prestabiliti. Un fatto che aveva colpito l'immaginazione di Louis de Broglie, il celebre scienziato francese, quando si incamminò “Sui sentieri della scienza” (Torino 1962): “Il fanciullo è curioso. Quanto nel mondo lo circonda, lo sorprende e lo stupisce... Più tardi, nella maggior parte degli uomini, tale curiosità universale diminuisce o per lo meno si attenua e si restringe a determinati campi .... L'umanità nel corso della sua evoluzione ha seguito, nelle sue linee generali, una via analoga a quella che seguono i singoli uomini nel corso della loro esistenza ... E' nata così la scienza moderna, figlia dello stupore e della curiosità: queste due molle segrete le assicurano sempre progressi incessanti. Ogni nuova scoperta ci apre nuovi orizzonti e contemplandoli noi siamo presi da nuovi stupori e da una rinnovata curiosità”
|