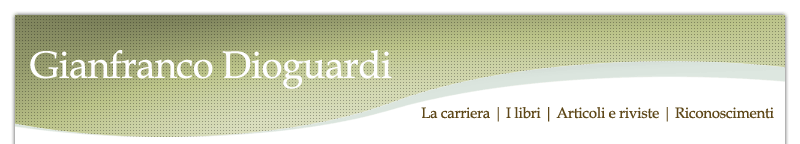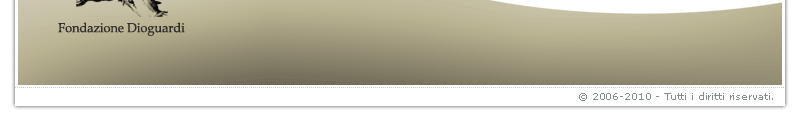|
 Alla ricerca dello spirito imprenditoriale Alla ricerca dello spirito imprenditoriale
 La Delega tecnologica La Delega tecnologica
 L'imprenditore nella complessità e nei mutamenti degli scenari di new economy L'imprenditore nella complessità e nei mutamenti degli scenari di new economy
 Strategia: antichi insegnamenti per l'imprenditore Strategia: antichi insegnamenti per l'imprenditore
 Elogio della fortuna imprenditoriale Elogio della fortuna imprenditoriale
 Dominare la nuova corte barocca imprenditoriale Dominare la nuova corte barocca imprenditoriale
 Parchi tecnologici Parchi tecnologici
 Strategia ovvero la struttura in azione Strategia ovvero la struttura in azione
 Imprenditore ovvero Entrepreneur Imprenditore ovvero Entrepreneur
 Infomatica:una nuova frontiera Infomatica:una nuova frontiera
PARCHI TECNOLOGICI
Sono nuove istituzioni che si stanno affermando nel mondo della ricerca applicata, dei servizi forniti alle imprese, dello sviluppo dell'innovazione economica. Due i grandi gruppi di specificazioni: il primo riguarda i parchi scientifici o di ricerca, indicati spesso come parchi tecnologici o tecnopoli, mentre il secondo si riferisce ai centri di innovazione e agli incubatori di aziende.
Di Gianfranco Dioguardi
E’ proprio nella piccola impresa che l'imprenditore può meglio interpretare la figura dell'innovatore così come la delineava il grande economista Joseph Schumpeter (1). In quella sede, infatti, l’imprenditore avendo avuto una nuova idea creativa - la business idea - è poi in grado di portarla più facilmente al successo attraverso le attività svolte dalla propria azienda. Ma quel successo può rivelarsi effimero, specialmente in tempi di rapido cambiamento dei gusti del pubblico, così come accade in particolare con la turbolenta new economy e con la globalizzazione dei mercati. E ciò rende indispensabile un processo di innovazione continuo e costante perché soltanto così l'impresa potrà consolidare con successo le sue quote di mercato.
Ecco allora che si rende necessario ipotizzare delle nuove specifiche strutture a carattere imprenditoriale, adatte a seguire proprio le piccole-medie aziende aiutandole nella loro gestione amministrativa per consentire all’imprenditore di concentrarsi invece sui processi di innovazione, affiancandolo soprattutto proprio nella ricerca applicata. Strutture in grado anche di esprimere, attraverso il coordinamento di rete delle varie imprese, un sistema interconnesso a livello nazionale capace di operare localmente ma con l’attitudine a pensare in termini globali, con utili sinergie per conquistare anche i difficili mercati esteri.
Tecnopoli
Mi riferisco a un genere nuovo di istituzioni che si sta affermando nel mondo della ricerca applicata, dei servizi forniti alle imprese, dello sviluppo dell'innovazione economica. Sono istituzioni che vengono chiamate con nomi diversi, ma con contenuti e scopi abbastanza simili.
Si sono così individuati due grandi gruppi di specificazioni: il primo è quello che riguarda i parchi scientifici o di ricerca, indicati spesso come parchi tecnologici o tecnopoli, mentre il secondo si riferisce ai centri di innovazione e agli incubatori di aziende.
Questi due gruppi appaiono complementari, comunque non indipendenti l'uno dall'altro, e la loro realizzazione deve avvenire in un clima di serietà, di non provvisorietà, di concretezza imprenditoriale.
La Comunità Economica Europea nella sua Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1990 ha fornito un vero e proprio lessico esplicativo.
“Parco scientifico” (science park), “parco di ricerca” (research park), “parco tecnologico” o “tecnopoli” (technology park) rappresentano iniziative territoriali di solito sviluppate con la collaborazione di università e di centri avanzati di ricerca, con i quali si instaurano collegamenti operativi per svolgere ricerca, tradurla in innovazione in particolare nel campo delle alte tecnologie e compiere trasferimenti tecnologici alle imprese del territorio, incoraggiando contemporaneamente la creazione, attrazione e sviluppo di nuove attività economiche. E ancora, i “Centri di innovazione” (innovation centre), gli “incubatori commerciali” (business incubator), i “parchi commerciali” (commercial/business park) sono istituzioni analoghe, volte alla creazione e all'assistenza di nuove e vecchie imprese impegnate comunque nello sviluppo e nella commercializzazione di innovazioni di prodotto e di processi.
Innovazione imprenditoriale
Queste istituzioni hanno il compito fondamentale di aiutare gli imprenditori e le loro imprese a innovare costantemente i propri processi produttivi con l'aiuto delle nuove tecnologie, e quindi a innovare anche i prodotti realizzati. Così, aiutando l'imprenditore a trasferire sempre nuove innovazioni nell’impresa si fa anche in modo di renderla più flessibile e più adattabile alle turbolenze che “l'età dell'incertezza” di John K. Galbraith (2) e "l'epoca della non ragione” di Charles Handy (3) impongono allo scenario ambientale.
Le nuove istituzioni sono dunque distribuite in una molteplicità di modelli organizzativi, che emergono nel mondo della ricerca emigrando verso scenari più specificatamente economici. Queste istituzioni devono necessariamente accompagnare le innovazioni tecnologiche da trasferire alle imprese che operano sul territorio, con processi di formazione avanzata fornendo anche servizi d'alta specializzazione, così da agevolarne lo sviluppo economico. In tal senso possono perciò stimolare anche nuove attività produttive, sia generando nuove aziende sia attirando imprese già attive verso il territorio nel quale operano.
Nuove imprese
Sono istituzioni che si configurano come vere e proprie «nuove imprese», mediante le quali è possibile sviluppare forme innovative di governo economico del territorio, cercando di collegare il mercato che regola i distretti industriali con le azioni di quei manager che operano nelle grandi imprese, individuando e coordinando le aziende del loro indotto, organizzandole in vere e proprie «macroimprese».
Il governo dell'economia diffusa, attuato attraverso strutture, quali i distretti tecnologici e le macroimprese, può essere agevolato e sviluppato mediante l'aiuto di queste nuove istituzioni, in modo da realizzare forme più evolute del classico coordinamento di mercato attuato dalla metaforica mano invisibile di Adam Smith (4). Già Alfred Chandler (5) aveva pensato di chiamare in causa una "mano visibile" che fosse l'espressione concreta della volontà manageriale e imprenditoriale di condizionare con l'offerta anche la domanda, e quindi l'intero mercato.
Reti virtuose
Il concetto di economia territorialmente diffusa porta a considerare sistemi più complessi per organizzare la gestione di tale economia e le mani visibili e invisibili sembrano trasformarsi in vere e proprie reti, solo in parte concretamente espresse dalle transazioni economiche in essere sul mercato. In buona parte, infatti, sono reti invisibili perché legate sia alle infrastrutture high tech sia, più in generale, a situazioni di imprenditorialità diffusa in grado di creare una atmosfera che ricorda molto da vicino la concezione descritta da Alfred Marshall (6) -- un'atmosfera di attrazione determinata da un'aggregazione spesso misteriosa di fattori tangibili e intangibili, che nel loro insieme sanno attribuire il successo a una situazione piuttosto che a un'altra.
Grazie alle nuove istituzioni, le mani invisibili e quelle visibili possono essere collegate e coordinate in reti virtuose in grado di distribuire alle imprese innovazioni e servizi, somministrando loro formazione e quindi determinando quelle condizioni culturali che poi favoriscono, anche e concretamente, la nascita e lo sviluppo di nuove attività economiche.
Missioni culturali
Ecco allora che l'attività puramente economica finisce con l'assumere una dimensione diversa, di vera e propria missione culturale e sociale, che va portata avanti senza naturalmente dimenticare l'obiettivo utilitaristico. Una missione che per essere espletata deve attivarsi grazie a una stretta e attenta collaborazione fra gli imprenditori e la pubblica amministrazione, e ciò con la mediazione delle nuove istituzioni.
Affinché tutto ciò possa attuarsi è indispensabile sviluppare in queste istituzioni alcune funzioni che possono assumere un'importanza fondamentale. Occorre, per esempio, costruire il concetto di manutenzione conservativa e preventiva, da programmare come processo sociotecnico in grado anche di educare preliminarmente gli utenti a un uso corretto dei beni loro affidati. In questo senso anche l’utilizzo dei prodotti generalmente high tech tende a diventare sempre più complesso e si rende necessaria una sorta di manutenzione culturale per costruire una “educazione” del cliente al corretto uso di ciò che oggi gli offre la produzione industriale nel campo manifatturiero e, in particolare, nell’ambito delle alte tecnologie.
In questo senso, la manutenzione va rivisitata come una nuova scienza.
Qualità
Al concetto di manutenzione è strettamente collegato l'obiettivo della qualità, e per questo è necessario impostare programmi che vanno perseguiti in modo razionale all'interno delle nuove istituzioni perché si accumulino specifiche esperienze da trasferire poi sul territorio e non soltanto nei distretti e nelle aree industriali, ma anche e soprattutto sulle città per restituirle alla società civile attraverso un attento e razionale uso delle alte tecnologie. In particolare va segnalato al proposito come proprio le imprese high tech, generalmente non inquinanti, tendono a ridistribuirsi sul tessuto urbano abbandonando quelle aree che un tempo erano esclusivamente dedicate alle attività industriali.
Le nuove istituzioni, così descritte, possono dunque costituire un importante strumento di sviluppo economico e sociale con l'obiettivo di meglio organizzare e anche rivitalizzare la new economy attuando una vera e propria iniezione di innovazione continua nelle imprese, in particolare in quelle di dimensione minore, che in essa operano o ad essa si vogliono riconvertire.
|